My single line text
My single line text
My single line text
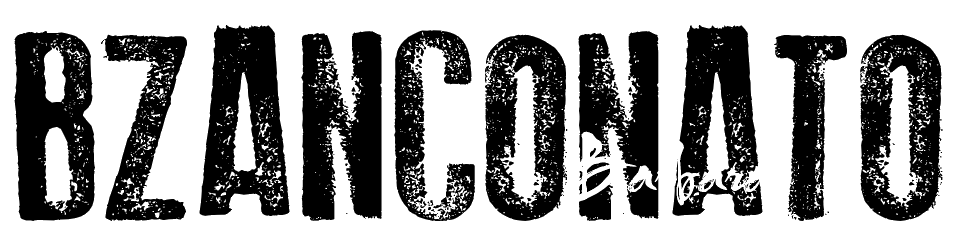
TESHUVA'
6^ Salon International d'Art Contemporain ART3F de Mulhouse
Mulhouse (F) 10-12 novembre 2017

Andrea Fallini
"Teshuvà" (תשובה) è un termine ebraico che viene spesso tradotto come "pentimento" ma in realtà significa letteralmente "ritorno". Ed è certamente in questa accezione che B.Zanconato l’ha scelto come titolo per la sua esposizione al Salon di Mulhouse. Anche in questo caso l’artista ha approfittato della sua presenza non solo per presentare le sue opere ma, soprattutto, per proporre al pubblico un percorso emotivo e una serie di riflessioni.
"Teshuvà" (תשובה), per B.Zanconato, è il simbolo del ritorno che l’uomo compie verso ciò che in realtà è la sua vera essenza, quel cammino di recupero (ed in questo sta il ritorno) verso la sua vera natura umana. In questo senso, comprende anche il significato corrente di pentimento dato che questo processo di cambiamento, di riappropriazione di se stessi implica, di fatto, il riconoscimento di comportamenti ritenuti negativi o per lo meno non adeguati, e di conseguenza l’intenzione di non ripetere, in futuro, lo stesso errore o lo stesso atteggiamento. Rilevante il fatto che, anche nella tradizione ebraica, il concetto di Teshuvà sia basato sulla fondamentale convinzione che l’uomo è in possesso del libero arbitrio, ovvero della capacità di scelta e della volontà di metterla in atto e che né l’eredità del passato, né le condizioni ambientali e né gli impedimenti materiali, sono tali da bloccare la potenzialità umana di cambiare e di migliorare.
Con questo preambolo in mente e di fronte all’opera centrale della mostra (“Wall of Dolls”) lo spettatore può risultare disorientato. L’opera infatti, che l’autrice definisce “devanture”, prende spunto dal tema della violenza sulle donne e presenta lo slogan che ricorrentemente viene pronunciato in dibattiti, discussioni pubbliche e dai media: Education is the key (l’educazione è la chiave). Nell’opera di B.Zanconato, in realtà, lo slogan è posto in forma interrogativa (Is education the key, cioè “è l’educazione la chiave”?) e costituisce una sorta di barriera, di muro (wall) sul quale emergono delle candide figure alate poste a testa in giù, bambole (dolls) a rappresentare simbolicamente le vittime delle violenze. Ma l’educazione è veramente la chiave di tutto? E quale educazione?
Di fronte alle continue violenze riportate dalle cronache, con l’opera "Wall of Dolls", l’artista intende portare l’attenzione sull’ipocrisia della catarsi collettiva di cui quotidianamente siamo testimoni. Manifestazioni, prese di posizione, iniziative politiche ripropongono lo sterile cliché riassunto dallo slogan Education is the key ed ogni volta nuove iniziative vengono lanciate nelle scuole (che nella visione corrente sono le sole sedi autorizzate ad impartire la buona educazione) senza peraltro affrontare la questione nella sua più ampia complessità.
Certamente sensibilizzare al rispetto le nuove generazioni è cosa quanto mai utile, ma la questione di fondo che si pone, e che non emerge mai in occasione delle violenze quotidiane nei confronti delle donne, è l’assenza di una analisi profonda dello stato dei rapporti di genere e la completa mancanza di una nuova visione coerente col messaggio che viene lanciato. Quanto, infatti, può risultare efficace una campagna di sensibilizzazione volta ad eliminare le discriminazioni uomo-donna se poi, nella pratica, le differenze di genere restano alla base dei comportamenti quotidiani (che
Certamente sensibilizzare al rispetto le nuove generazioni è cosa quanto mai utile, ma la questione di fondo che si pone, e che non emerge mai in occasione delle violenze quotidiane nei confronti delle donne, è l’assenza di una analisi profonda dello stato dei rapporti di genere e la completa mancanza di una nuova visione coerente col messaggio che viene lanciato. Quanto, infatti, può risultare efficace una campagna di sensibilizzazione volta ad eliminare le discriminazioni uomo-donna se poi, nella pratica, le differenze di genere restano alla base dei comportamenti quotidiani (che

fanno da esempio ai più giovani), dei modelli sociali e della concezione dei rapporti uomo-donna a tutti i livelli? È forse sufficiente demonizzare i comportamenti estremi, che portano ai femminicidi, quando poi, come riportato dalle più recenti statistiche, una donna su tre ha subito e continua a subire atti di violenza? O forse affrontare la questione in modo ampio, diretto, pratico, mettendo in discussione la diversità stessa di genere come elemento identificativo, risulta troppo rivoluzionario e destabilizzante?
Questo mascheramento della questione chiave sta alla base delle modalità espressive utilizzate dall’artista: innanzi tutto, come detto, lo slogan è stato riproposto in termini di domanda (dove però è omesso il punto interrogativo), ma, soprattutto, la rappresentazione è caratterizzata da forti elementi grafici tipici della pubblicità e del marketing. Con quest’opera B.Zanconato sembra dirci che questo modo di procedere non è altro che pubblicità, azione di facciata, una “devanture” (il termine è normalmente utilizzato per indicare l’allestimento esterno di molti negozi francesi) perché non cambierà mai nulla sino a quando considereremo le persone in base al loro genere, le educheremo e le spingeremo ad atteggiamenti diversi a seconda del loro sesso di appartenenza. E a guardar bene le dolls che B.Zanconato ha inserito nella sua opera sono prive di riferimenti sessuali, per sottolineare come le vittime dell’attuale “educazione” e mentalità non sono in realtà solo le donne ma gli stessi uomini, anche loro soggetti a un clima culturale che li ha cresciuti inculcando il concetto della dominanza di genere: un uomo è tale solo se domina e a lui non può essere riconosciuto alcun tipo di fragilità.
Questo mascheramento della questione chiave sta alla base delle modalità espressive utilizzate dall’artista: innanzi tutto, come detto, lo slogan è stato riproposto in termini di domanda (dove però è omesso il punto interrogativo), ma, soprattutto, la rappresentazione è caratterizzata da forti elementi grafici tipici della pubblicità e del marketing. Con quest’opera B.Zanconato sembra dirci che questo modo di procedere non è altro che pubblicità, azione di facciata, una “devanture” (il termine è normalmente utilizzato per indicare l’allestimento esterno di molti negozi francesi) perché non cambierà mai nulla sino a quando considereremo le persone in base al loro genere, le educheremo e le spingeremo ad atteggiamenti diversi a seconda del loro sesso di appartenenza. E a guardar bene le dolls che B.Zanconato ha inserito nella sua opera sono prive di riferimenti sessuali, per sottolineare come le vittime dell’attuale “educazione” e mentalità non sono in realtà solo le donne ma gli stessi uomini, anche loro soggetti a un clima culturale che li ha cresciuti inculcando il concetto della dominanza di genere: un uomo è tale solo se domina e a lui non può essere riconosciuto alcun tipo di fragilità.
L’argomento della prevaricazione introdotto da “Wall of dolls” è enfatizzato da un’altra opera in mostra a Mulhouse: “The child bride”. Il soggetto è quello delle spose bambine che, ignare di ciò che le aspetta e illuse dall’atmosfera di festa e dall’abito nuziale, sono cedute in spose a uomini adulti nel rispetto di una crudele tradizione di matrimonio che le considera alla stregua di merci viventi da barattare all’interno di un accordo economico e di comodo tra famiglie.
Solo apparentemente il tema tocca costumi e abitudini sociali che oggi ci appaiono distanti: infatti diversi casi di spose bambine sono stati denunciati anche nelle nostre società (seppure nell’ambito di famiglie provenienti da aree geografiche in cui questa pratica è ancora in uso). Inoltre, solo poche generazioni fa anche in Italia (se non in Europa) molte ragazze erano costrette dalla famiglia a sposare, per motivi diversi, uomini che non si erano scelti per non parlare del fatto che non potevano decidere la direzione di vita e la professione che
Solo apparentemente il tema tocca costumi e abitudini sociali che oggi ci appaiono distanti: infatti diversi casi di spose bambine sono stati denunciati anche nelle nostre società (seppure nell’ambito di famiglie provenienti da aree geografiche in cui questa pratica è ancora in uso). Inoltre, solo poche generazioni fa anche in Italia (se non in Europa) molte ragazze erano costrette dalla famiglia a sposare, per motivi diversi, uomini che non si erano scelti per non parlare del fatto che non potevano decidere la direzione di vita e la professione che

avrebbero voluto fare. Ma il tema qui non è solo quello della violenza doppiamente subita da queste bambine (da parte del marito che le avvia, non ancora pronte e coscienti, alla vita adulta e da parte della famiglia o del padre di famiglia che, più come un padrone che come un padre, ne fa materia di commercio) ma è anche e soprattutto quello dell’atavico e non ancora superato diritto di supremazia maschile, incentrato sulla forza e sulla violenza, e che ingabbia ancora il destino di tante donne (e al contempo anche di tanti uomini) che hanno subito e subiscono sin dall’infanzia questa sorta di indottrinamento. È chiaro che le conseguenze di questo tipo di visione e di “educazione” risultano eclatanti se non al limite, nei casi delle spose bambine ma va detto che, subdolamente, sono ancora insinuate nella mentalità e nella vita quotidiana di molti di noi: per tanti motivi, tutti di comodo, restano tacitamente latenti….. sino a quando, per le ragioni più diverse, riemergono con modalità estreme, sempre violente.
Questo elemento di camuffamento, cioè di presenza di una sorta di doppia morale che porta a condannare pubblicamente le conseguenze estreme di aspetti che in realtà sono impliciti nella mentalità ancora corrente, che risulta al centro delle prime opere in mostra, riemerge potentemente anche in un’altra opera di B.Zanconato, un’altra devanture in mostra a Mulhouse: “G.R.”.
Questo elemento di camuffamento, cioè di presenza di una sorta di doppia morale che porta a condannare pubblicamente le conseguenze estreme di aspetti che in realtà sono impliciti nella mentalità ancora corrente, che risulta al centro delle prime opere in mostra, riemerge potentemente anche in un’altra opera di B.Zanconato, un’altra devanture in mostra a Mulhouse: “G.R.”.
“G.R.” rappresenta da un lato una riflessione sulla verità (quella dei media, in prima battuta, influenzata da comprensibili motivi di audience, legati allo stesso business dell’informazione, ma anche quella dell’opinione pubblica, che pare appoggiarsi direttamente su quella dei media e che col passare del tempo, subisce un inesorabile processo di degradazione) dall’altro una riflessione sulla superficialità emotiva collettiva di fronte ai fatti di violenza e sulle sue ragioni. Il caso di Giulio Regeni (le cui iniziali danno il titolo all’opera) è un emblematico ulteriore esempio: immediatamente dopo la tragica scomparsa del giovane ricercatore italiano in Egitto, i social di tutto il mondo e le piazze di molte città italiane sono stati tappezzati da manifesti e striscioni gialli inneggianti alla “verità”. Ma a distanza di tempo, tutto questo si è – per così dire - “ossidato”.
Ed è questo atteggiamento di facile ossidazione emotiva che l'artista vuol mettere in evidenza
Ed è questo atteggiamento di facile ossidazione emotiva che l'artista vuol mettere in evidenza

con questa opera: tutta l’empatia iniziale si è consumata nel giro di poco tempo e si è esaurita con l’esibizione di qualche striscione (soprattutto a livello di rappresentanze politiche) o con la pubblicazione del cartello giallo sul proprio social, oppure con l’aver apposto un like su qualche pagina internet. Così è stato anche per altri episodi che si sono verificati in Europa negli ultimi anni, dove questo bisogno di presa di posizione, per tanti, si è risolto ed ha trovato la sua catarsi attraverso facili manifestazioni simboliche spesso messe in atto attraverso i social (ad esempio la pubblicazione di una immagine rappresentativa sulla propria pagina web). E questo è l’aspetto interessante: la partecipazione cioè l’esserci ma come parte di un gruppo, anche se per un breve momento, diventa l’elemento essenziale forse ancor di più del manifestare il proprio pensiero di fronte a questi fatti di violenza.
E la relazione col gruppo è al centro di “Io voglio TU DEVI”. “Io voglio TU DEVI” riassume, con una lapidaria sintesi grafica, il conflitto dell’individuo immerso nella società contemporanea. Infatti, da una parte, in un angolo buio se ne sta l’individuo e la sua debole volontà, simbolizzata dalla scritta in corsivo Io voglio, oppressa se non minacciata da un grande imperativo: TU DEVI. TU DEVI è l’espressione delle varie componenti della vita contemporanea che sottopongono l’individuo ad una interminabile serie di pressioni al fine di condizionarne il comportamento. E la leva sulla quale tutto si gioca è il senso di appartenenza. L’appartenenza alla famiglia in fondo ha sempre comportato delle regole che hanno imposto certi comportamenti (le donne questo lo sanno da sempre). Ma la società contemporanea ha ampliato questo concetto: appartenere al gruppo significa disporre degli ultimi ritrovati tecnologici, perché altrimenti si è off; appartenere al gruppo significa essere sempre in forma; appartenere al gruppo significa indossare una delle uniformi all’ultima moda; appartenere al gruppo significa avere sempre un aspetto giovane e affascinante, come testimoniato dai modelli pubblicitari di cui siamo quotidianamente bombardati e che ci mostrano qual'è la via per la felicità. Si tratta di seguire le regole e le tradizioni, si tratta di dare ascolto a quanto ci viene suggerito dagli specialisti del settore, di seguire i trends del momento, di inseguire il successo che porta a maggiori possibilità economiche per estendere le possibilità di accumulo di oggetti sempre nuovi, alla ricerca di quell'appagamento e quella felicità che sembrano dipendere

dalla nuova ricetta che ogni giorno ci viene proposta e che, guarda caso, dovrebbe valere per tutti ma non vale per nessuno. Peccato, però, che le mode cambino (è il concetto stesso di moda che lo certifica), che gli ultimi ritrovati tecnologici divengano obsoleti in tempi brevissimi e che i modelli di riferimento siano inarrivabili: in sostanza, se da una parte la felicità come appagamento è a portata di mano, in realtà non arriva mai oppure è destinata a non durare. E questo alla lunga destabilizza, aumenta il senso di inadeguatezza e di sfiducia in se stessi innescando, come conseguenza, un senso di solitudine, quella solitudine che, la società demonizza come il peggiore dei mali ma che forse, a guardar bene, così negativa non è.

La solitudine è il tema di “Before”. “Before” ci presenta parte di un volto di donna come vista attraverso lo spioncino di una cella oppure attraverso una piccola finestrella. E la superficie lignea che circonda il volto enfatizza la separazione, esalta la presenza di un muro che si erge tra lo spettatore e la figura femminile che è rappresentata come colta durante una sua riflessione, all’interno di un suo mondo. Simbolo della sua solitudine all’interno delle mura domestiche? Forse. Oppure, al contrario simbolo di quella solitudine che aiuta e che serve ad andare dentro se stessi, della concentrazione e del silenzio necessari a cogliere la propria voce profonda, alla ricerca dei nostri veri valori e delle cose in cui crediamo veramente. O ancora simbolo di quella solitudine della quale molto spesso abbiamo paura e per la quale accettiamo false amicizie, accettiamo di presenziare a manifestazioni di cui ci sfugge il senso e di condividere momenti privati con perfetti sconosciuti, che ci fa dire raramente ciò che pensiamo.
P. Mercier nel suo “Treno di notte per Lisbona” descrive benissimo questo stato di cose: “La solitudine che paventiamo: in che cosa consiste in fin dei conti? Nel silenzio di rimostranze sottaciute? Nel non dover più avanzare con cautela, trattenendo il respiro, sul campo minato delle bugie coniugali e delle verità tra amici? Nella libertà di non aver nessuno davanti a sé quando si pranza? Nell’abbondanza di tempo che si dischiude quando si ammutolisce il tambureggiamento degli appuntamenti? Non sono tutte cose meravigliose? Uno stato paradisiaco? In cosa consiste allora il timore? Non si tratta alla fin fine di un timore che sussiste per il solo fatto che non abbiamo esaminato fino in fondo il suo oggetto? Un timore che ci è stato inculcato dai discorsi sconsiderati di genitori, insegnanti, preti? E perché siamo così sicuri che gli altri non ci invidierebbero se vedessero quanto è cresciuta la nostra libertà? E che non cercherebbero la nostra compagnia proprio per questo?”
P. Mercier nel suo “Treno di notte per Lisbona” descrive benissimo questo stato di cose: “La solitudine che paventiamo: in che cosa consiste in fin dei conti? Nel silenzio di rimostranze sottaciute? Nel non dover più avanzare con cautela, trattenendo il respiro, sul campo minato delle bugie coniugali e delle verità tra amici? Nella libertà di non aver nessuno davanti a sé quando si pranza? Nell’abbondanza di tempo che si dischiude quando si ammutolisce il tambureggiamento degli appuntamenti? Non sono tutte cose meravigliose? Uno stato paradisiaco? In cosa consiste allora il timore? Non si tratta alla fin fine di un timore che sussiste per il solo fatto che non abbiamo esaminato fino in fondo il suo oggetto? Un timore che ci è stato inculcato dai discorsi sconsiderati di genitori, insegnanti, preti? E perché siamo così sicuri che gli altri non ci invidierebbero se vedessero quanto è cresciuta la nostra libertà? E che non cercherebbero la nostra compagnia proprio per questo?”
In risposta a queste domande intriganti vengono altre due opere “Skeleton” e “MAKES a DIFFERENCE”. La prima riprende in modo più esplicito il tema dell’introspezione, dell’andare a scavare nel profondo della nostra essenza umana per individuarne gli elementi costitutivi e fondamentali. Il simbolo dello scheletro (skeleton) a questo riguardo è estremamente potente: lo scheletro infatti è l’elemento corporeo che sorregge se stesso e il restante insieme di organi ed apparati. Inoltre è la parte del corpo che maggiormente resiste nel tempo. Di conseguenza, quanta e quale parte dei nostri comportamenti è legata alla nostra essenza di individui unici ed irripetibili e quanta e quale è invece determinata da sovrastrutture che ci sono state fatte indossare e che si sono sedimentate ed indurite nel tempo? A questo riguardo l’artista sembra riprendere il mito greco di Er, secondo il quale, prima della nascita ogni anima si sceglie un destino, un paradigma che ne influenzerà il comportamento in vita e che poi avrà la possibilità di portare a compimento. Ma una volta confermata e resa ineluttabile da parte delle Moire la scelta fatta dall’anima, alla stessa viene assegnato un demone custode. Prima di scendere nel mondo le anime sostano nella pianura del fiume Lete e sono obbligate a berne l’acqua. L’acqua del Lete è in grado di far dimenticare. Quelle di loro che non riescono a trattenersi ne bevono molta e saranno quelle che meno ricorderanno la loro scelta.
Il genio tutelare, tuttavia, non beve l’acqua e quando insieme all’anima viene lasciato cadere sulla terra rimane consapevole del destino a cui è rimasto incatenato: il suo compito è quello di guidare l’anima verso il compimento di quest’ultimo.
Il genio tutelare, tuttavia, non beve l’acqua e quando insieme all’anima viene lasciato cadere sulla terra rimane consapevole del destino a cui è rimasto incatenato: il suo compito è quello di guidare l’anima verso il compimento di quest’ultimo.

"Skeleton" per B.Zanconato è simbolo della nostra essenza cioè di quel paradigma che la nostra anima si è scelta e la cui realizzazione rappresenta il motivo per cui siamo venuti al mondo. Nel tempo però questo paradigma viene ricoperto da strati e strati di sovrastrutture che ci vengono imposte, sin dalla più tenera età, attraverso l’educazione e che via via viene sostituito da proiezioni che ci impediscono anche di sentire i suggerimenti che il genio tutelare dà a ciascuno sottoforma di intuizioni, sogni, passioni.

Ecco perché il processo di introspezione e di individuazione dell’essenza umana di ciascuno è strettamente legato alla solitudine: occorre infatti prendere una certa distanza dalle cose, dalle persone, dalle situazioni per poter vedere lucidamente cosa ci appartiene e di cosa, invece, possiamo e dobbiamo liberarci o, in altri termini, per meglio sentire la voce della nostra guida interiore. E allo stesso tempo, questo dialogo interiore, dà origine al pensiero (al nostro pensiero) e alla definizione dei nostri valori.
È solo così che impareremo a ri-conoscere noi stessi: ricordando la nostra essenza e individuando le nostre aspirazioni più profonde. Solo allora prenderemo possesso della nostra vita anziché rincorrere con affanno un generico mito della felicità che ci viene propagandato come incluso nei beni che troviamo nei negozi ma che poi, ad acquisto fatto, si rivelano deludenti.
Realizzare le nostre potenzialità, sviluppare i nostri talenti: è questo che fa la differenza ("MAKES a DIFFERENCE"). Fare le cose perché dentro di noi c’è una forza inarrestabile che ci spinge a farle; seguire una direzione nella nostra vita perché sentiamo che, nonostante tutto, quella è la nostra direzione. Credere profondamente in certi principi e valori perché li sentiamo come nostri e li viviamo in prima persona. Credere nella nostra unicità ed irrepetibilità; credere in noi e nelle nostre capacità di giudizio. Credere che abbiamo un potenziale da sviluppare: questo fa una grande differenza!
È solo così che impareremo a ri-conoscere noi stessi: ricordando la nostra essenza e individuando le nostre aspirazioni più profonde. Solo allora prenderemo possesso della nostra vita anziché rincorrere con affanno un generico mito della felicità che ci viene propagandato come incluso nei beni che troviamo nei negozi ma che poi, ad acquisto fatto, si rivelano deludenti.
Realizzare le nostre potenzialità, sviluppare i nostri talenti: è questo che fa la differenza ("MAKES a DIFFERENCE"). Fare le cose perché dentro di noi c’è una forza inarrestabile che ci spinge a farle; seguire una direzione nella nostra vita perché sentiamo che, nonostante tutto, quella è la nostra direzione. Credere profondamente in certi principi e valori perché li sentiamo come nostri e li viviamo in prima persona. Credere nella nostra unicità ed irrepetibilità; credere in noi e nelle nostre capacità di giudizio. Credere che abbiamo un potenziale da sviluppare: questo fa una grande differenza!
"Teshuvà" (תשובה), l’opera in esposizione che dà il titolo di insieme alla mostra, è la sintesi di tutti questi temi. L’invito che l’artista sembra lanciare è di prendere le distanze da atteggiamenti e manifestazioni di facciata, di non aver timore di restare fuori dal gruppo, dal coro di voci tutte uguali, ma al contrario di instaurare un dialogo profondo con noi stessi e recuperare la nostra vera essenza. Teshuvà quindi, nel senso etimologico del termine: torniamo a noi stessi, ai nostri veri bisogni e aspirazioni, alla nostra vera essenza che non ha bisogno di uniformi per proteggersi, che non ha bisogno di un genere per identificarsi. Come la sottile figura umana delineata nell’opera: uomo o donna, poco importa. Ciò che conta è il cammino, l’avanzare, il fare, il creare, senza avere sovrastrutture e pesi inutili che impacciano (come il telo rosso che sta per volare via), senza avere catene che bloccano (come quelle che pendono ai lati). Teshuvà, con la fiducia che questa possibilità è nelle nostre mani e che né l’eredità del passato, né le condizioni pratiche di oggi possono arrestare le nostre potenzialità di cambiare e di migliorare noi stessi.

E con la fiducia che questo potrebbe avere un effetto anche sulle relazioni con gli altri. Questa è l’ educazione che auspica l’artista e che potrebbe essere effettivamente la chiave del cambiamento.
“Crearsi la libertà,
crearsi un sacro no anche di fronte al dovere….
Prendersi il diritto a nuovi valori
È il prendere più terribile che vi sia…”
F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”
crearsi un sacro no anche di fronte al dovere….
Prendersi il diritto a nuovi valori
È il prendere più terribile che vi sia…”
F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”
